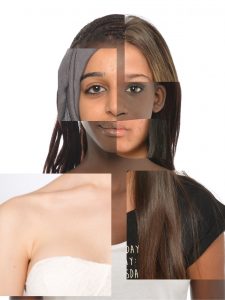Per fare ordine tra queste pratiche, può essere utile organizzarle per classi Pais e Provasi 2015:
1. rental economy: il noleggio di beni che sarebbero sottoutilizzati se posseduti direttamente dai privati organizzato da aziende (è il caso del car sharing, come Car2go o Enjoy);
2. economia peer-to-peer: anche in questa classe rientrano beni altrimenti sottoutilizzati, in questo caso offerti direttamente dai loro proprietari (è il caso di piattaforme di ospitalità come Airbnb);
3. economia on demand: piattaforme di intermediazione di servizi professionali forniti anche da non professionisti (come TaskRabbit, ancora assente in Italia);
4. monete complementari: analoga alla classe precedente, ma sostituisce il denaro con crediti o con tempo come unità di valore dei servizi scambiati (come nella banca del tempo digitale TimeRepublik);
5. open source: programmi software prodotti da comunità di sviluppatori e utenti avanzati, che li rendono disponibili gratuitamente a condizione che non vengano privatizzati (es. Linux); logiche analoghe vengono applicate nella condivisione delle infrastrutture di rete, dall’energia elettrica al wifi.
6. finanza collaborativa: dal social lending al crowdfunding (la piattaforma più nota è Kickstarter).
Includendo nell’analisi anche musica e video streaming servizi, la società di consulenza PwC 2015 ha stimato che l’economia di condivisione oggi genera un valore di 15 miliardi di dollari rispetto ai 240 miliardi dall’economia tradizionale per gli stessi settori, e prevede che entro il 2025 la somma raggiungerà 335 miliardi di dollari, pari al 50% del valore totale. Secondo la recente indagine promossa da Burson-Marsteller, The Aspen Institute e Time 2016 45,3 milioni di adulti americani (il 22% della popolazione) hanno già offerto almeno un servizio di sharing economy e 86,5 milioni ne hanno usufruito (42%).
Se si passa dall’attitudine al comportamento, i dati disponibili presentano un quadro più ambiguo. La ricerca Burson-Marsteller, The Aspen Istitute e Time conferma le aspettative: i 18-34enni americani producono e usano servizi di sharing in misura superiore alla media (28% vs 22% come produttori e 51% vs 42% come consumatori).
Altre ricerche mettono in discussione questo risultato o permettono di scendere più in profondità nell’analisi. La ricerca Nielsen, pur confermando la maggiore attitudine dei Millennials alla condivisione dei beni (in media, 35% vs 17% dei 35-49enni e 7% degli over 50), rileva forti differenze territoriali: in America Latina, per esempio, gli over 50 sono molto attivi. Questi risultati aprono una riflessione interessante sulle “varietà della sharing” (per richiamare la letteratura sulla varietà dei capitalismi), legate anche ai tratti culturali di ogni contesto socioeconomico.
La ricerca VisionCritical e Crowdcompanies distingue tre categorie: i non sharers, persone che non hanno mai sperimentato servizi di sharing economy (60% della popolazione USA e 48% UK); re-sharer, che comprano o vendono beni di consumo utilizzando piattaforme consolidate come eBay o Craiglist (16% Usa e 29% Uk) e neo sharers, che utilizzano i servizi emergenti come Etsy, TaskRabbit, Uber, Airbnb e Kickstarter (23% Usa e 25% Canada). Quasi la metà dei neo sharers (48%) ha tra i 18 e i 34 anni. Il rapporto esclude l’ipotesi che lo sharing possa rappresentare solo una fase di passaggio per giovani che, non potendo ancora permettersi l’acquisto, si accontentano dell’accesso a beni in condivisione; al contrario, rileva una prevalenza di persone affluenti tra gli utenti delle piattaforme sharing.
Questi dati sono coerenti con la maggiore propensione dei Millennials all’utilizzo del digitale, anche per transazioni commerciali: il 94% è utente di internet (vs 71% della popolazione), l’87% è iscritto almeno a un social network (vs 60%), l’84% utilizza lo smartphone (verso 53%) e il 61% ha acquistato almeno un prodotto o servizio sul web nell’ultimo anno (contro il 28% dei 35-64enni).